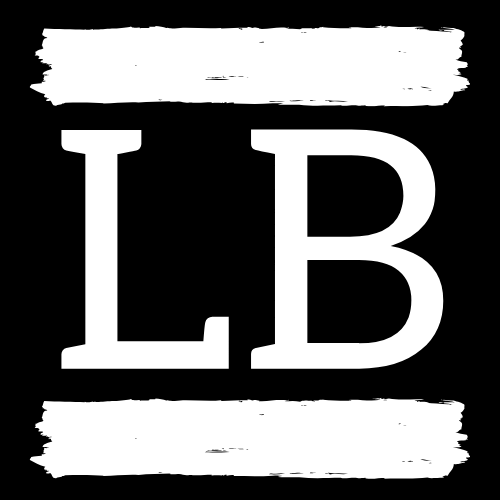Borgo Moschino
Il ragno zampettava sulla strada sterrata. Era grosso, nero e pigro, e una pallida luce rosata ingigantiva la sua ombra.
Un istante prima di schiacciarlo sotto il suo stivale, Zolicheur si chiese se avesse coscienza di cosa stava scendendo su di lui, e se il suo istinto sarebbe stato quello di provare a scappare. Quel pensiero finì con uno scricchiolio sotto la suola, appena percettibile, soffocato dal rombo del Po. Il fiume scorreva sotto gli archi del ponte di pietra che collegava Torino alla collina, per poi lambire il fetido intrico di vicoli e capanne chiamato Borgo Moschino. Rami, fronde e altri rifiuti galleggiavano e passavano veloci, scomparendo dietro i platani.
Dopo dodici settimane di assedio non c’erano più battelli a solcare le acque. Nemmeno quelli notturni dei contrabbandieri, che costituivano una parte consistente della fortuna di Zolicheur.
E che adesso non ho più, grazie alla fottuta guerra del fottuto duca con i fottuti francesi.
Lo chiamavano Zolicheur, joli coeur, perché il suo cuore era tutto tranne che tenero. Perché mettergli i bastoni tra le ruote significava un mare di guai. Guai per chi non pagava la protezione, guai per gli sbirri e per gli amici degli sbirri. Guai per chi non si faceva gli affari propri e per chi gli rovinava gli affari.
Qualcuno lo stava facendo, però, sotto il suo naso: quelli che da qualche tempo rapivano gli abitanti del Moschino per portarli chissà dove a fare chissà cosa.
Zolicheur fece la strada a ritroso, tornando verso le baracche, gli occhi nervosi a scavare nelle ombre sempre più lunghe. Quello era il suo borgo, come sue erano le puttane, la refurtiva e le merci di contrabbando. Provare a togliergli ciò che era suo era come provare a togliere al Duca il palazzo nella piazza del Castello: significava mettere il mondo alla rovescia, e lui non aveva alcuna voglia di iniziare a vivere con la testa all’ingiù.
Raggiunse un gruppo di uomini fermi a ridosso di un muretto coperto di edera.
«Ci sono tutti» disse una figura alta. Al riparo dalle ultime luci del giorno, nascondeva i lineamenti sotto il mantello e il tricorno.
«Ciascuno vada al suo posto» ordinò Zolicheur.
Li guardò allontanarsi, i suoi uomini, freddi e duri come lui, con le armi nascoste sotto le giacche o appese alle cintole. In cielo l’ultimo raggio di sole si estingueva per cedere il posto a una tenebra mista a nuvole gonfie di pioggia.Zolicheur si guardò attorno, ruotando su se stesso: tutto gli dava la sensazione di essere immobile, avvolto nel silenzio, ma questo non significava che non ci fosse qualcuno nascosto in agguato. Attraversò la strada là dove un platano segnava il cortile della “cà dle tre Boche”. Si fermò per qualche istante tra le erbacce altissime e le liane di edera rampicante, prima di andare ad acquattarsi contro una delle pareti annerite dal fumo.
Ogni volta che tornava in quel luogo, che fosse giorno o notte, qualcosa lo tratteneva e gli toglieva il fiato: nessun presentimento, nessuna minaccia concreta. Soltanto ricordi.
Ai tempi in cui a Torino governava il vecchio Duca accanto alla sua bella sposa francese, in quella specie di locanda vivevano tre ragazze, e si diceva fossero sorelle, figlie illegittime di un nobile fuggite a Torino, damigelle della Madama Reale cadute in disgrazia: di certo avevano modi da signore che le altre puttane del borgo non sarebbero mai riuscite a imitare. Le chiamavano “le Tre Bocche”, o con altri soprannomi meno gentili. C’era Bocca d’Oro, che con le labbra ci sapeva fare, Bocca Asciutta che invece non ci sapeva fare per niente. E Bocconcino, la preferita dei clienti.
Dopo aver tenuto testa alla guerra, alla povertà e alle malattie, ai clienti ubriachi e a quelli che menavano le mani, erano crepate per una candela accesa e un soffio di vento, e della casa in riva al fiume erano rimasti solo ruderi e storie di paura. Si raccontava di vagabondi che all’imbrunire avevano cercato riparo in quelle rovine, e al mattino dopo erano scomparsi. E a voce più bassa, qualcuno parlava di patti diabolici che ogni tanto riportavano le Tre Bocche sulla terra, a sedurre le anime come un tempo avevano fatto con i corpi.
Anche se li aveva cercati, Zolicheur non aveva mai incontrato fantasmi tra i resti di quella che un tempo era stata la sua casa. Un tempo molto lontano, prima che la carità dei preti e la solerzia degli sbirri lo chiudessero in un orfanatrofio. Sua madre era Boconìn, Bocconcino, e ora che era un uomo, ora che di puttane ne aveva avute molte, Zolicheur poteva capire perché lei piacesse tanto. Non era solo bella: aveva una piega naturale sulle labbra, da far credere che il suo sorriso fosse autentico.
Zolicheur l’aveva sognata qualche notte prima, e nel sogno sua madre sembrava terrorizzata: lo guardava e cercava di parlargli, ma con parole che Zolicheur non era riuscito a sentire. Si era risvegliato con un residuo di rabbia, frustrazione e un vago senso di allarme.
In cielo le nuvole cedettero e la pioggia prese a cadere increspando il Po, grondando le fronde, inzuppando il cappello e la giacca, il tessuto, la pelle e le ossa. Zolicheur ripensò al ragno nero: si chiese se avesse presagito l’arrivo del temporale e se lui l’avesse sorpreso mentre andava a mettersi al riparo.
La pioggia scese, le ore trascorsero. Il cielo non si era ancora acceso dei colori dell’alba quando Zolicheur trasalì e una sorta di prurito prese a solleticargli la base del collo. Le sue orecchie avevano avvertito un rumore poco davanti a lui: uno scalpiccio lieve, forse di un ratto o un cane randagio.
Sentiva il cuore pulsare e il battito ripetersi in sincronia sulla tempia. Avvertiva qualcosa di strano nella notte calda e umida, nella pioggerellina impalpabile e perfino nella cappa che impregnava l’aria, avvelenata dagli umori delle fogne che scaricavano nel fiume le lordure di Torino.
A quel fetidume era abituato, ma allora perché gli sembrava così fastidioso? Perché perfino le baracche di legno e paglia sembravano diverse, più nitide, come se avessero voluto emergere o fuggire dalle ombre?
Cominciò a contare in silenzio per mantenere la concentrazione.
Uno. Due. Tre.
Ebbe la curiosa sensazione di essere sospeso nel vuoto, poi di precipitare, come quando si è sul punto di addormentarsi: solo che era del tutto sveglio. Sveglio e pieno di rabbia.
Sette. Otto.
Nessuno può entrare nel mio territorio e farla franca.
Nove. Dieci. Undici. Dodici.
Come non l’aveva fatta franca lui, la prima volta. Il boia gli aveva marchiato la fronte con la V di voleur, il marchio d’infamia dei ladri.
Vi marchierò altro che la fronte!
Tredici. Quattordici.
Lo scalpiccio di poco prima si ripeté, adesso più forte e solido. Quando fu arrivato a venti, Zolicheur vide una figura scura staccarsi da
dietro la fila di capanne. Nel ritaglio di luce proiettato dalla lanterna che reggeva in mano schizzavano le gocce di pioggia, rimbalzando sul vetro. La figura indossava un mantello e portava il tricorno sulla testa: affondò il piede in una pozzanghera facendo un suono umidiccio. Alle sue spalle, un’altra sagoma. Poi una donna fece capolino, i capelli fradici schiacciati sulla testa: la pioggia le aveva sciolto il trucco segnandole le guance. La pioggia o il pianto? Un pensiero che passò per la mente di Zolicheur, ma senza mettere radici. La sua attenzione era altrove.La ragazza era una delle tante che si vendevano nelle sudice taverne in riva al Po, e che pagavano la protezione a Zolicheur. Si muoveva senza esitare né cercare di ribellarsi, uno strano comportamento per una che era stata rapita, o costretta contro la sua volontà.
Lei è d’accordo! Sono tutte d’accordo!
Ecco perché spariscono senza lasciare traccia!Zolicheur sentiva il cuore pulsare così in fretta che non riusciva più a distinguere i battiti. Avrebbe voluto cominciare a correre e iniziare subito il lavoro di coltello. Si sentiva invaso, allagato da quella voglia.
No, non subito. Con calma. Molta calma.
Più tardi avrebbe dato a quella puttana un esempio buono per tutte le altre.
Dopo che avrò finito con lei, perfino a un lebbroso farà schifo toccarla.
Fece un profondo respiro e uscì dal nascondiglio, strisciando nelle ombre, appoggiando i piedi con passo così delicato da affondare nel fango senza rumore, lo sguardo fisso sulla luce della lanterna che si allontanava.
Man mano che raggiungeva uno dei punti di guardia stabiliti cominciavano a muoversi i suoi compari, e quando la piccola processione attraversò il ponte, la banda era al completo.
Dall’altra parte del Po, le chiome degli alberi che ricoprivano le pendici fluttuavano alla brezza fresca e Zolicheur ebbe l’impressione che tutto il monte fosse in movimento. La sua mente fu accarezzata da quella visione, i pensieri si lasciarono cullare danzando al ritmo ipnotico. Fu l’odore a richiamarlo indietro. Un odore repellente che metteva voglia di voltarsi e darsela a gambe. Ma proprio quella sensazione aveva avuto il potere di svegliarlo dallo strano torpore di un istante prima.
Distanti qualche decina di passi, quelli che Zolicheur stava pedinando oltrepassarono un’osteria, e i due uomini seduti davanti alla soglia li guardarono senza fare commenti, come se non ci fosse stato niente da vedere.
(Come se non avessero visto niente. O come se avessero fatto finta di non vedere niente)
Due ubriachi o due complici?
La puzza aumentava. Sembrava stringersi tutt’intorno, poi aprirsi di forza un varco nelle narici ed entrare anche se si respirava solo con la bocca. Era qualcosa di diverso dal miscuglio di sterco, pesce marcio e sudore a cui Zolicheur era abituato vivendo tra le case di borgo Moschino.
Cosa può avere quest’odore? si domandò, e una parte di lui riuscì a rispondere: un mucchio di carcasse. Un mucchio molto grosso. Un grosso cumulo di carogne lasciate marcire sotto il sole.
Passò davanti alla taverna e guardò l’ubriaco seduto sui gradini: dormiva, la testa china sui ciottoli del cortile. Una lampada a olio spandeva lampi di luce tremula sulle guance e sul naso che sembravano rosso sangue.
Tornò la puzza, e questa volta suggerì la sensazione di un respiro mefitico esalato da un’invisibile nebbia.
Gli ubriachi erano due, ricordò Zolicheur, e un brivido lo percorse mentre un mormorio gli sfiorava le orecchie e una nebbia lattiginosa s’insinuava nella sua testa. Un’ombra prese forma davanti a lui e riempì il vicolo di tenebre più scure e minacciose della notte. Un’ombra enorme, ma che apparteneva a un essere con due braccia, due gambe e… una testa di cane.
Zolicheur sentì il fiato strozzarsi in gola e un gemito uscirgli dalle labbra socchiuse. La sua vescica ebbe un fremito, implorando di svuotarsi. Cercò di estrarre il coltello, ma la sua mano si rifiutò di obbedire, come se fosse stata insensibile, o come se fosse stata la mano di qualcun altro.
È tutto inutile. Adesso mi ammazza.
Attorno a lui si mossero altre ombre.
I suoi compari cominciarono a gridare.
E anche Zolicheur gridò, quando vide cosa si stava abbattendo su di lui.
***
La Cittadella
I cannoni della batteria francese spararono di nuovo. Passepartout sentì l’aria vibrare, lo scricchiolio dei mattoni sotto pressione, la polvere sbriciolata che scendeva su di loro.
«Cos’è stato?» Cordìn affondò lo sguardo nell’oscurità. «Sembrava …»
«Zitto» ordinò Passepartout. L’aria viziata e piena di polvere rimandò echi della sua voce. Rimase fermo con le orecchie tese, il respiro trattenuto in gola. Si scoprì di pensare che sarebbe stato più semplice se quel tratto di galleria fosse stato illuminato. Si scoprì di desiderare la luce e quel pensiero lo sorprese. Dopo due mesi e mezzo in compagnia dell’oscurità delle gallerie sotto la Cittadella, Passepartout si era abituato a trascorrere interi giorni senza vedere una luce. Al buio si era abituato a spostarsi e aspettare, a consumare il rancio e perfino a caricare le armi. Ma c’erano dei momenti, durante le guardie, in cui il silenzio era talmente fitto che ogni minima vibrazione, ogni minimo scricchiolio parevano riempire l’oscurità di nemici in agguato. In quei momenti Passepartout non riusciva a scacciare la sensazione di essere osservato da occhi feroci e carichi d’odio. E allora, mentre cresceva in lui qualcosa di molto vicino alla paura, giungeva prepotente il desiderio che ogni cosa fosse ben illuminata.
Negli ultimi giorni i nemici avevano fatto progressi con gli scavi e le loro gallerie si erano avvicinate di molto. Da una settimana in corrispondenza del bastione San Maurizio si fronteggiavano i minatori francesi e quelli sabaudi, gli uni sabotando il lavoro degli altri. Il capitano Bozzolino aveva aumentato la sorveglianza sotto la mezzaluna di Soccorso, sicuro che presto i francesi avrebbero cercato di penetrare da quella parte. I rumori di zappe e picconi risuonavano al di là delle pareti di mattoni, giorno dopo giorno, come pesanti conferme. Il nemico era vicino, sopra e intorno a loro, ma finora stava scavando a vuoto.
Passepartout lasciò uscire il fiato in un sospiro di sollievo.
«Falso allarme?» chiese Cordìn a bassa voce.
«Falso allarme.»
Se e quando i francesi fossero riusciti a intercettare una delle gallerie difensive, il primo segno sarebbe stato il gemito di mattoni frantumati, poi un tremendo boato e una cascata di terra e detriti che scendeva dall’alto. In quel momento, invece, anche i picconi tacevano. Prima di arruolarsi, Passepartout era stato un muratore. Un muratore disoccupato con una moglie da mantenere e un figlio in arrivo. Con l’unica alternativa di soffrire la fame, aveva scelto di vestire l’uniforme blu dei minatori del Duca di Savoia. Nessuno era bravo come lui a infilarsi nei luoghi angusti, così avevano preso a chiamarlo Passepartout, “passa dappertutto”.
Suo padre, Giacomo Micca, lo aveva fatto battezzare col nome di Pietro.
«Si staranno ancora leccando le ferite dopo l’assalto dell’altro giorno» disse Cordìn. «Ma prima o poi ci riproveranno, questo è sicuro.»
Continuava a fissare le tenebre con uno sguardo a metà strada fra il pensieroso e il preoccupato. Quattro giorni prima i francesi avevano lanciato contro le fortificazioni esterne il più feroce assalto alla baionetta dall’inizio dell’assedio. Secondo i disertori catturati, l’attacco aveva impegnato dieci battaglioni e venti o venticinque compagnie di granatieri. Le bandiere con il giglio avevano sventolato per tutta la notte sulle piazzeforti e lungo il cammino coperto davanti alla mezzaluna, finché il contrattacco non li aveva respinti. Non da tutte le posizioni, però.
«Se dopo due mesi e mezzo tutto quello che sono riusciti a conquistare sono due piazzaforti ai lati di una mezzaluna, possiamo far sapere al Principe Eugenio di fare con calma che qui ce la caviamo benissimo.»
«Non scherzare, Passepartout» ammonì Cordìn. «Che venga più presto che può, il Principe Eugenio.»
«Credi che non me lo auguri anche io? Voglio solo tornare da mia moglie e conoscere mio figlio.» Passepartout non riuscì a impedirsi di fare un debole sorriso, e al tempo stesso di rabbrividire. Fino a quel momento le difese sotterranee avevano retto bene quanto quelle di superficie, ma ogni progresso del nemico di sopra avrebbe avuto conseguenze anche sotto. E adesso i francesi controllavano gli angoli ai lati della mezzaluna.
Un rumore sottile arrivò dal buio pesto del cunicolo. Il raschiare di piccole zampe.
«Un topo.» La voce di Cordìn aveva una strana sfumatura di incertezza.
«Hai paura dei topi, adesso?»
Cordìn scosse la testa.
«Qui non sono né i topi né i francesi a farmi paura.»
La prima volta che era sceso nelle gallerie, Passepartout aveva ripensato alle sinistre leggende di cui gli avevano parlato i veterani e il sangue gli si era mutato in ghiaccio. Adesso era un veterano anche lui, e sapeva che il “respiro del Diavolo”, la polvere da sparo bruciata che uccideva i minatori, era il pericolo più grande perché non faceva rumore e non aveva odore. I topi facevano rumore. I francesi facevano rumore e puzzavano.
«C’è davvero qualcuno» disse Cordìn in un sussurro bassissimo.
«Cosa?»
«Ascolta.»
Per un attimo, quando avvertì l’odore, Passepartout credette che fosse uno scherzo della sua immaginazione. Per un attimo pensò che lo stava sentendo perché ci aveva appena pensato. No. Anche Cordìn l’aveva avvertito. Puzza di sudore, aglio e cipolle mal digerite. Passepartout sentì un brivido lungo la schiena. Il suo cuore perse un battito. I francesi erano entrati nella galleria.
Come abbiamo fatto a non sentirli?
Dovevano aver fatto la breccia più avanti, dalla parte delle loro trincee, approfittando della salva di cannone della batteria per far saltare i mattoni del soffitto. Trovò a tastoni la pistola che teneva alla cintura, la impugnò mentre allungava l’altra mano verso Cordìn. In silenziosa sintonia cominciarono a risalire la galleria, dirigendosi verso il posto di guardia dove avrebbero trovato rinforzi. Sotto i loro piedi, il pavimento di pietra era levigato, cosparso di briciole di mattoni caduti dal soffitto. Insidie difficili da evitare nel buio. Bastava calpestarne una per frantumarla come un cristallo e diffondere il rumore a metri di distanza. Passepartout cercava di spostare con attenzione il peso per non far rumore, ma sentiva il tintinnare metallico che facevano la fibbia della giberna e il fodero della baionetta. E naturalmente anche lui puzzava.
Un colpo di fucile frantumò il silenzio insieme all’illusione di non essere scoperti. Passepartout vide un’eruzione di scintille esplodere dalla parete accanto a lui. Il sapore dolciastro della paura gli riempì la gola. Aprì le labbra per dire… cosa? Non lo sapeva nemmeno lui. Le parole gli erano rimaste congelate nella testa, la voce in gola. Sapeva solo che aveva cominciato a correre mentre altri spari tuonavano alle sue spalle. Dall’oscurità cominciarono a emergere delle ombre, circonfuse da un contorno dorato che Passepartout riconobbe come quello proiettato da lanterne con i vetri schermati. Le ombre erano sacchi di terra disposti a formare uno sbarramento. Al di là dei sacchi altre sagome, immobili anch’esse: soldati sabaudi. Cordìn raggiunse il posto di guardia per primo e la sua sagoma venne come inghiottita da quella più grande del muro di sacchi messo a sbarramento del passaggio. Passepartout fu lì un istante dopo: si appiattì contro il riparo e sussurrò una preghiera alla Madonna della Consolata.
Adesso tutti sparavano e la paura aveva ceduto il posto a una fredda determinazione. Prese la pistola dalla cintura e strinse tra i denti la bacchetta di caricamento per avere la mano libera e riempire la canna con la polvere, la stoppa e la palla. Il sapore del metallo gli scese in gola. Aveva compiuto quell’operazione così tante volte che riusciva a farla a occhi chiusi, ma sempre con la massima attenzione, dal momento che ogni errore poteva costargli la vita. Il suo vecchio istruttore gli teneva compagnia anche se non era davvero accanto a lui.
“Tieni la canna in verticale! Non schiacciare troppo la palla contro la polvere! Impugna la bacchetta in modo che non ti buchi la mano se parte un colpo! Viso lontano dalla canna!”
Passepartout sparò, caricò, sparò di nuovo. L’aria era di fiamme e fumo.
«Indietro!» comandò finalmente una voce, quella del sergente. I soldati uscirono dai ripari: una fila ordinata e silenziosa, con moschetto in spalla e berrette di lana sulla testa, che si stagliava nelle tenebre della galleria.
Passepartout si unì alla ritirata trattenendo il fiato, riducendo il numero e la durata dei respiri per non lasciarli preda di quello del Diavolo. I suoi passi cominciavano a farsi pesanti e certo non solo per la stanchezza. Appena possibile avrebbe dovuto bere molta acqua per purgarsi. Udì alle sue spalle uno scroscio simile a quello di una grandinata. Un suono che la prima volta che aveva sentito aveva trovato terrificante: erano i soldati del Duca che per ostruire il passaggio stavano facendo franare della ghiaia dalle gallerie di sopra attraverso i pozzi dell’aria. Poi avrebbero completato l’opera facendo esplodere delle bombe. Raggiunsero un tratto di galleria dove brillavano le lampade alle pareti: un rassicurante segno di aria respirabile. Passepartout ne inspirò una profonda boccata e chiuse gli occhi.
«Ben fatto!» Sentì esclamare il sergente. «Stasera doppia razione di rancio!»
Intorno a sé altre voci si scambiarono risate e congratulazioni.
Per cosa? Si chiese Passepartout. Per avere difeso questa galleria? Per avere obbedito agli ordini, per avere sparato contro i nemici?
Si appoggiò contro la parete di mattoni e lasciò che le spalle si afflosciassero.
Ho ucciso degli uomini stanotte?
Non lo sapeva, ma il pensiero di averlo fatto lo rattristò, come lo rattristava ogni volta. Si fece il segno della croce e chiese perdono a Dio.
Stavo solo facendo il mio dovere: è tutto quello che può fare un uomo. Difendo la mia patria e cerco di rimanere vivo. Stanotte è andata bene.
Chiuse gli occhi e prese un altro lungo respiro. Il nemico stava stringendo le sue maglie attorno alla Cittadella: i cannoni che tiravano contro la mezzaluna erano sempre più precisi e aprivano una breccia sempre più larga. Quando i detriti della breccia fossero stati abbastanza da poterli scalare, i francesi avrebbero lanciato un altro assalto alla baionetta. Ben più deciso e poderoso di quello di qualche giorno prima. Il grande assalto da cui si sarebbero decise le sorti della Cittadella e di Torino.
Dietro le palpebre chiuse apparve il viso di Maria Caterina, nitido e sorridente come la ricordava nel giorno del loro matrimonio. E apparve quello più vago di suo figlio Giacomo Antonio che ancora non aveva conosciuto. Passepartout immaginò di dare un bacio a quei due visi. Poi seguì i suoi compagni a occupare le nuove posizioni di difesa.
***
Un sotterraneo
La vittima fece un verso simile allo squittio di un topo, quando il carnefice cominciò a inciderle il ventre. Il gemito si tramutò in urla, la ragazza iniziò a contorcersi con violenza sotto la carezza della lama, nel disperato quanto inutile tentativo di sottrarsi alla mutilazione. Luigi Rossotto studiava la perfezione dei gesti, la precisione dei tagli. Un ballerino non avrebbe potuto essere più aggraziato. Era così vicino all’altare da sentire l’odore caldo e metallico del sangue: deglutì nello sforzo di restare fermo. Per la prima volta gli era stato concesso l’onore di reggere la coppa dell’offerta. Un altro scalino, sempre più in alto nelle gerarchie del culto.
Aveva tempo, tutta una vita. E poi, tutte le vite che il Drago gli avesse concesso di vivere… e di prendersi, possedere, schiacciare come formiche: vite come quella della la ragazza che si dimenava sull’altare, annegando nel suo sangue. Il pensiero era così grandioso che gli fece venire le lacrime agli occhi.
«Continua a guardare» sibilò una voce vicinissima al suo orecchio. Era quella del Primo Sacerdote. Il suo profumo intenso e speziato emanava note misteriose, di cui le più facili da distinguere erano menta, cannella e incenso.
Luigi si irrigidì, trattenendo il fiato. Immobile come pietra continuò a guardare, temendo di fare qualunque cosa di diverso, anche deglutire o respirare. Aveva paura che perfino il sudore che gli colava sulla faccia per la vicinanza alle fiamme del braciere fosse qualcosa di troppo. Guardò il lavoro del coltello e delle tenaglie, del ferro rovente e della lama seghettata. A ciascuno il suo compito: tagliare, strappare, bruciare, suturare. L’eccitazione di fronte all’agonia era così forte che ogni battito del cuore gli sembrava trasmette fitte agli occhi e li facesse gonfiare.
«Ti piacerebbe se fossi tu a farlo?»
Luigi si chiese se quella del Primo Sacerdote fosse una domanda o un’offerta.
Sì, ti prego. Ti prego fallo fare a me!
O una prova. Non c’era scelta tra i seguaci del Drago: mangiare o essere mangiati, uccidere o morire, godere o soffrire.
«Sì.» Luigi ebbe il timore di avere avuto un’esitazione di troppo. Si raschiò la gola e ripeté, più forte: «Sì.»
Io voglio farlo. Sono pronto a farlo. Non vedo l’ora di farlo.
Si sentiva ribollire di piacere.
«Quale momento preferisci, Luigi?»
Un’altra domanda che celava una prova. Luigi sapeva che il Primo Sacerdote sentiva la menzogna nelle parole, perché poteva leggere i pensieri. Si voltò a guardarlo. Non era più alto di lui eppure dava una sensazione di maestosità così sovrumana da mettere i brividi. Sotto il mantello e la veste si intravedeva la forma di un corpo tozzo ma forzuto.
«Da quando andiamo a prendere la vittima nella cella» rispose «fino al suo ultimo istante di lotta per restare viva. Mi piace quando resiste.»
Un angolo della sua mente suggerì un’altra immagine. A volte, quando già il suo sangue era stato versato tanto da lordare il pavimento sotto l’altare, la vittima rivolgeva al carnefice uno sguardo docile di sottomissione e colmo di qualcosa che pareva… speranza. Luigi non sapeva spiegarsi perché capitasse, e perché si sentisse ogni volta martellare il cuore in petto, gli occhi umidi, i lombi brucianti di eccitazione. Quello sguardo gli faceva pensare a un cagnolino che scodinzola leccando la mano di chi gli porge il cibo.
«Un giorno forse sarai tu il carnefice» disse il Primo Sacerdote. Luigi comprese che le risposte erano state di suo gradimento.
Ma io voglio farlo subito! Quel pensiero gli sorse spontaneo. Un pensiero ribelle, pericoloso, la voce dell’ambizione che lo animava. Un pensiero che gridava con una voce troppo alta, anche se non aveva pronunciato una sola parola.
«Ricordati cosa sei. E cosa non sei ancora.»
Cosa sei? Gli aveva chiesto il Primo. Lui era Luigi Rossotto, figlio del dottor Rossotto. Aveva portato alla follia quella demente della sua sorellastra, le aveva fatto credere di essere una strega, spingendola a uccidere e uccidere ancora. Le aveva fatto togliere di mezzo il loro sciocco padre e poi l’aveva sacrificata, diventando unico padrone della fortuna di famiglia. Era sfuggito alla giustizia degli sbirri e a quella dei nemici del Dio Drago che si facevano chiamare Figli del Toro. Aveva preparato la nuova dimora del Dio Drago e ce l’aveva condotto. Era gli occhi del Dio Drago tra insetti che governavano una città di insetti.
E cosa non sei? Non era compiuto. Ma compiaceva la volontà del Dio Drago da quattro anni, e non ne aveva ancora compiuti venti. Il tempo era dalla sua parte.
Intanto la vittima aveva smesso di lottare, e Luigi si sentì rattristato. Non c’era più gusto nel suo dolore, se non lo esprimeva. Fu allora che udì le voci al di là della porta del tempio. Delle chiavi sferragliarono, dei cancelli si chiusero, poi fece il suo ingresso uno dei sacerdoti. Luigi sapeva che erano cinque, compreso il Primo. Li aveva visti tutti insieme solo la notte in cui il Dio Drago aveva aperto gli occhi. Non aveva idea se vivessero nella villa in collina che adesso, per merito suo, ospitava nuovamente il tempio. Sapeva solo che ogni tanto qualcuno di loro tornava dalla città con nuove vittime da sacrificare. Così doveva essere stato anche quella notte.
Il sacerdote attraversò la grande sala tra le colonne già annerite dal fumo, anche se i colori erano stati ripassati e i dipinti restaurati da poco meno di due mesi. I fedeli riuniti in preghiera si aprirono in due ali per lasciarlo passare e raggiungere la scalinata: la maggior parte abbassò la testa al suo cospetto, altri, i membri più giovani e gli ultimi arrivati, si misero in ginocchio.
Furono ignorati. Non erano ancora degni nemmeno del suo sguardo. Il sacerdote salì tre, quattro gradini, poi si fermò al cospetto del Primo. Entrambi indossavano le maschere di cerimonia: quella del Primo, d’oro anziché di gesso dipinto, era il simbolo del suo potere e del suo privilegio.
«Eccoti qui, dunque, mio incauto amico.» La voce del Primo era calma e gentile, in un modo che a Luigi ricordò il suono di un flauto. Eppure la parola ‘incauto’ suggeriva un rimprovero, e il rimprovero sulle labbra del Primo non era mai di buon augurio.
«Ho portato a termine il mio dovere» disse il sacerdote. Luigi credette di riconoscere una nota nervosa. Forse invece era solo quello che si aspettava di sentire. Ricordati chi sei e chi non sei, lo aveva ammonito il Primo, e senza dubbio Luigi sapeva di non essere come loro.
Loro non provavano le emozioni nello stesso modo di chiunque Luigi avesse conosciuto. Sembrava che nulla potesse sfiorarli davvero.
«Hai avuto qualche contrattempo.»
Era una constatazione o una domanda quella del Primo? Forse una domanda, perché l’altro rispose:
«Pensavano di averci teso una trappola.»
«Chi?»
«Una banda del Borgo Moschino. Non ci daranno più…»
«Hai lasciato tracce. Sei cadaveri.»
Il sacerdote non rispose e Luigi fu tentato di alzare lo sguardo. Respinse la tentazione. Aveva imparato sin dall’inizio che il veltro ha il solo dovere di servire il cacciatore, senza fare domande, senza intromettersi. Le questioni tra cacciatori non erano affare suo. Almeno per il momento.
«Quei corpi lasciati a marcire sotto il sole in riva al Po provocheranno domande e richiameranno sguardi» fece notare il Primo.
«Lo so. Al Moschino nessuna banda alzerà più la testa quando passiamo.»
«Adesso lo farà qualcun altro.»
Una lunga pausa.
«Non hanno…» cominciò a dire il sacerdote. Ci fu un sibilo, poi uno scrocchio seguito da un suono orribilmente umido. Un tonfo. Un altro più pesante. Luigi vide il corpo del sacerdote afflosciarsi sulla gradinata e la testa rotolare poco distante, la maschera di gesso spezzata.
Non dovrei guardare, pensò. Dovrei chiudere gli occhi.
I suoi occhi rimasero aperti, il cuore preda di una pericolosa eccitazione.
Il sacerdote era vecchio. No, era decrepito. Aveva un viso magro, un naso adunco, occhi pallidi e vuoti che il trucco rituale faceva apparire più grandi. E la pelle… era pelle che non vedeva da tempo la carezza del sole. Pallida e grinzosa, secca, sembrava cartapecora.
Nel silenzio del tempio, si sentiva solo il rantolo della vittima lasciata a morire sull’altare. Poi il Primo Sacerdote tornò accanto a Luigi e sussurrò:
«Abbiamo molte aspettative su di te. Non ci deludere.»
***
La Città Nuova
Gustìn aveva percorso il tratto di strada che dal Balòn conduceva alla Città Vecchia con la sensazione di galleggiare nella nebbia. Giunto di fronte al palazzo del Duca rallentò il passo e s’incamminò lungo la via Nuova, assaporando l’aria fresca della sera. Solo in quel momento si rese conto che aveva smesso di piovere. La sua attenzione era colma di un unico pensiero: amava Laura Chevalier e lei lo ricambiava. Rabbrividì, perché sapeva che quel sentimento l’avrebbe reso più debole, vittima di emozioni contro cui non aveva imparato a erigere difese.
Si fermò in piazza d’Armi e per la prima volta lo commosse l’atmosfera della Messa che da qualche notte veniva tenuta in quel luogo. Nell’aria risuonava il mormorio delle preghiere e il coro dei padri filippini, giovani cantori dalle voci angeliche, intervallati dalla voce stentorea del vecchio prete, dal corpo fragile come un giunco e il cuore d’un leone. Le torce tremavano ai lati del palco.
E Gustìn era innamorato.
Mi prenderò cura di lei.
Sentì un tuono, poi subito un altro, come l’annuncio di un nuovo temporale, ma questa volta il cielo rimase asciutto: il bombardamento sulla Cittadella era ricominciato.
Numerose carrozze si erano fermate all’angolo della piazza verso la Porta Nuova, e servitori in livrea erano schierati a inchinarsi alle dame e ai cavalieri che varcavano le soglie della chiesa di Santa Cristina. Gli abiti erano macchie di colori vivaci tra le ombre. Una Messa tenuta in una delle chiese preferite dagli aristocratici, e a beneficio di pochi privilegiati.
Nella Piazza delle Armi, su cui si affacciava la chiesa, padre Valfré celebrava un’altra Messa, al cospetto di tutti i torinesi che volessero ascoltarla. Soldati, nobili e plebei, gli uni accanto agli altri. Mentre cercava un posto dove fermarsi, Gustìn si guardò attorno per vedere se riconosceva qualcuno.
Il conte Nomis di Valfenera, il sindaco di Torino, era intento a farsi aria col cappello e sembrava distratto quanto Gustìn. Indossava un abito color ciclamino che non doveva esibire tanto spesso nelle occasioni ufficiali: il Duca predicava la sobrietà. Accanto al sindaco c’erano la moglie, rossa in viso e matronale nelle forme, e un giovane smilzo che doveva essere il figlio. Chissà se il conte aveva mai saputo delle malelingue che qualche anno prima avevano cercato di infangare la sua reputazione? Qualcuno aveva insinuato che per onorare certi debiti di gioco il sindaco avesse chiesto un prestito agli ebrei del Ghetto: voci che proprio Gustìn aveva dimostrato essere false, man mano che i testimoni svanivano come fumo.
Riconobbe l’erudito monsignor Dalla Casa e i due figli del marchese di Fleury: il più grande era suo coetaneo. Da bambino lo aveva convinto a scambiare il cappello con il suo. Naturalmente non gliel’aveva mai restituito. Il marchese di Fleury fece un passo indietro, rivelando la presenza di Maria Corona, sempre vestita con il suo inconfondibile abito nero e fuori moda. La dama era appena a una decina di passi. Gustìn sentì il cuore mancare un colpo.
Altri fedeli ascoltavano la Messa accanto a lei, eppure nessuno faceva segno di aver notato una figura che sembrava uscita da un quadro di almeno cinquant’anni prima. Nessuno, tranne il suo inseparabile cicisbeo Emilio: le labbra spesse, le narici rialzate e il sorriso sciocco gli conferivano un’aria fanciullesca, ma non bastavano a togliergli di dosso la sensazione di una bestia pronta a sbranare il primo che avesse infastidito la sua signora. Dopo averli visti combattere nelle gallerie di mina, Gustìn sapeva che Emilio ne sarebbe stato capace. Mentre si faceva avanti chiedendosi cos’avrebbe dovuto dire, la dama sollevò il viso per fissarlo negli occhi. Non mostrava stupore, come se avesse sempre saputo che l’avrebbe trovato lì.
“Continuate a servire Torino, monsieur Augusto. Abbiamo bisogno di voi.”
Il ricordo di quella preghiera, di come Maria gliel’aveva sussurrata la prima volta che si erano parlati, lo scosse fino a offuscargli la mente. Ricordò il senso di devozione che l’aveva sorpreso durante e dopo quell’incontro. Ora sapeva che quella devozione era frutto dei poteri sovrannaturali della dama. L’ultima volta che l’aveva vista era stato nella gallerie sotto la Cittadella. Maria aveva annichilito con un solo sguardo un gruppo di combattenti e poi aveva squarciato a morsi il collo di uno di loro. Prima di combattere, aveva dichiarato:
«Nous sommes les enfants du Taurus». Noi siamo i figli del Toro. E aveva aggiunto “Turin appartient au Taurus”.
Gustìn, stordito dal veleno respirato nella gallerie, aveva nutrito più di un dubbio su ciò di cui era stato testimone, sulle parole enigmatiche e sulla battaglia sovrumana che ne era seguita.
Sì, aveva visto e sentito. Da Tommaso e dai suoi libri erano arrivate conferme che suonavano come certezze. Maria e i Figli del Toro appartenevano a una setta chiamata “Cavalcanti”, che combatteva le streghe e i servitori del Demonio. E le leggende sulle origini di Torino parlavano di un Toro che era diventato protettore della città dopo aver sconfitto un Drago.
Ecco lo scenario che Gustìn aveva svelato, o credeva di aver svelato.
“Se certe cose sono rimaste segrete finora ci sarà un motivo. Se fossi in voi non andrei a spiattellarle in giro”.
Le raccomandazioni di Tommaso, mentre si avvicinava a Maria, gli fecero battere più forte il cuore. Ebbe l’impressione di vedere un rapido luccichio negli occhi di lei, una scintilla, e pensò: sa che conosco il suo segreto. Si levò il cappello e si piegò in un inchino, sfiorando con le labbra la mano che lei gli aveva offerto. Ebbe il tempo di notare anelli d’oro di squisita fattura.
«Sono felice di vedervi» disse, cercando di mostrarsi più calmo e deciso di quanto non fosse. «Dobbiamo parlare.»
«Immaginavo che l’avreste chiesto.» Maria fece un passo verso di lui e gli offrì il braccio.
«Signora…» sussurrò Emilio. «Non è un… bene che ti allontani…» Incespicava nelle parole, lo sguardo sperduto. Maria lo rassicurò con una carezza.
«Ascolta la predica. Dopo me la racconterai.» Poi si rivolse a Gustìn con un sorriso sulle labbra: «Posso essere io a guidarvi, signor Augusto?»
«Dove?»
«Dove orecchie indiscrete non sentano.» I suoi occhi brillarono di nuovo.
Si lasciarono alle spalle la piazza, la Messa di padre Valfré, i fedeli ed Emilio. Il buon senso parlò alle orecchie di Gustìn. Non seguirla, diceva, se sa che l’hai smascherata potrebbe volerti mettere a tacere per sempre. Al buon senso rispose l’istinto: solo lei può aiutarti a capire.
Passarono davanti alle scuderie del principe di Carignano e oltrepassarono un cancelletto che dava sul cortile interno di un palazzo. Gustìn riconobbe il vecchio chiostro che la gente chiamava ancora “il Cortile dei Preti”, benché fosse sconsacrato da tempo. Comprese che stavano entrando nel ghetto degli ebrei.
Maria si fece strada ignorando le persone che incontravano, e venendone allo stesso modo ignorata. Tutti esibivano, come prescritto dalla legge, un vistoso nastro di lana gialla. Gli uomini portavano la barba, le donne avevano i capelli coperti da velette. Tutt’intorno si aprivano botteghe di oggetti usati e in alto, lungo i ballatoi, bagliori di candele e voci sommesse rivelavano che in quel luogo viveva qualcuno.Gli edifici che formavano quell’isolato della Città Nuova erano stati resi abitabili in ogni angolo, con soppalchi e stanze una sull’altra dove i soffitti alti lo consentivano.
Gustìn afferrò qualche parola delle conversazioni intorno a loro, in un dialetto che mescolava torinese e giudaico. La battaglia della notte precedente, il prezzo del pane, le bombe che cadevano: il ghetto non si sottraeva alle stesse paure dei quartieri che lo circondavano, chiudendolo come un muro.
Senza che nessuno le facesse domande o cercasse di fermarla, Maria aprì un cancello di ferro e iniziò a scendere una rampa di scale che si perdeva nel buio, ma all’ultimo momento sembrò ricordarsi di Gustìn. E dell’assenza di luce. Gli indicò un rilievo su cui era appoggiata una lanterna accesa.
«Prendetela e seguitemi.»
Raggiunsero le cripte di quella che un tempo era stata una chiesa. Molte delle nicchie erano chiuse con muri di mattoni o porte di legno rinforzate da borchie e strisce metalliche. Gustìn era pronto a scommettere che era dove gli usurai del ghetto nascondevano i loro tesori più preziosi. Imboccarono un corridoio che scendeva ancora. Lunghi festoni di ragnatele erano appesi alle volte, e la polvere si sollevava dal pavimento al loro passaggio. Gustìn respirò odore di muffa, erbe secche, pagine di pergamena.
Maria si fermò davanti a un’altra porta, e mentre lei cercava la chiave in qualche tasca del suo abito, Gustìn alzò la lampada per studiare le decorazioni: due teste di toro in rilievo, una di fronte all’altra. Il ferro era corroso dalla ruggine. La porta si aprì cigolando, e Gustìn scoprì un luogo che sembrava la sala di un vecchio castello. Due armature vuote vigilavano sull’ingresso. Le pareti accoglievano arazzi di paesaggi boschivi dalle varie tinte di verde. Il profumo di muffa era coperto da quello di fiori freschi e incenso.
«Dove siamo?» chiese Gustìn.
«In un posto sicuro.»
«Dunque ora mi direte la verità?»
«Ci sono domande a cui non potrò dare risposta. La vostra vita sarebbe in pericolo, se parlaste di queste cose con le persone sbagliate.»
«Non fareste prima a dirmi quali sono le persone sbagliate?»
«Se lo sapessi, monsieur Augusto, non avrei bisogno del vostro aiuto e voi non sareste qui.»
Gustìn abbassò gli occhi sul pavimento. Quella risposta lo aveva raggelato.
«Vi ho visti combattere nelle gallerie sotto la Cittadella» bisbigliò.
«Lo so. Sono stata io a portarvi fuori.»
E lei era stata ferita, ricordò all’improvviso Gustìn. Ricordò di avere visto le unghie animalesche di una specie di uomo chiamato Faucigny calare sulla spalla della dama, affondare nella carne, schizzare sangue. Maria però sembrava godere di ottima salute. Chissà perché, Gustìn non riusciva a stupirsene.
Con lei, non si stupiva più di nulla. Nemmeno della facilità con cui riusciva ad affrontare un discorso che in altre circostanze, e con chiunque altro, si sarebbe ben guardato di pronunciare.
«Gli archivi del Duca contengono testimonianze e atti di processi per stregoneria contro quelli come voi. Vi chiamano Cavalcanti, Benandanti… o in altri modi ancora.» Gustìn non riuscì a dire che alcuni dei nomi che aveva letto significavano “morti che camminano”.
«Noi siamo qui da molto tempo, monsieur Augusto. Molto, molto tempo.» Una breve esitazione increspò i lineamenti della dama, e altrettanto rapida scomparve. «Sin dall’inizio ci è stato insegnato ad amare questa città e i suoi abitanti. Questo è tutto quello che posso dirvi per il vostro stesso bene.»
Vi fu l’eco di uno scoppio. Una bomba era di nuovo caduta sulla Città Nuova, qualche metro sopra di loro. Gustìn si rendeva conto di essere di fronte a qualcosa che sfuggiva a ogni tentativo di spiegazione. Ciascuna delle domande che gli vorticavano in testa ne avrebbe fatte emergere altre ancora, come anelli di una catena sollevata da sotto la sabbia. Si concentrò sulle risposte, quelle di cui aveva bisogno per formulare ipotesi sulla sua indagine. Ignorò il resto. E chiese:
«Qualche settimana fa, alla festa di La Feuillade, un ufficiale ha fatto cenno a strana gente arrivata a Torino insieme al Duca d’Orleans. Il conte Gropello è convinto che si tratti di sicari chiamati a colpire i nostri generali, ma nel campo francese si parla di demoni evocati dal Duca d’Orleans in un qualche rito diabolico. Sono quelli con cui avete combattuto voi ed Emilio?»
Anche lo stupore, sul viso di Maria, aveva una sfumatura di dolcezza.
«La congrega di Faucigny. La nostra contesa è di lunga data.»
E voi siete qui da molto tempo, pensò Gustìn con un brivido.
«Le persone scomparse su cui sto indagando… sono loro a rapirle…» Esitò, per un istante colto da una sensazione di trepidazione e terrore. «O uno di voi?»
Aveva aggiunto quelle ultime parole d’un fiato, indeciso fino all’ultimo se pronunciarle o no. Maria storse la bocca in una smorfia di fastidio e dolore, il primo cedimento di un viso che sembrava scolpito in un’eterna serenità.
«Ci sono voci che parlano di un tradimento nella nostra congrega. Voci che arrivano da molto lontano e che per questo meritano molta attenzione.»
Anche Gustìn aveva sentito una di quelle… voci. In uno strano sogno, aveva incontrato il suo amico Milo, morto quand’erano bambini, che cercava di metterlo in guardia da un traditore nascosto “Tra i figli del Toro”.
«Durante la battaglia, l’altra notte …» Prese fiato, esitò. «Qualcuno ha gridato “dite ad Amedeo che non ho tradito Torino”.»
Gli occhi della dama vibrarono e Gustìn pensò che fosse sul punto di piangere.
«Efialte» sussurrò Maria sfiorando il nome come una carezza, «tradì il suo signore in un altro tempo e un altro luogo. Quello di traditore è un marchio d’infamia di cui non bastano mille vite per liberarsi.»
Dunque era proprio lo stesso Efialte di cui parlavano i libri di Tommaso, vissuto prima della nascita di Gesù Cristo. E Gustìn stava parlando con la stessa dama che aveva riconosciuto in un ex voto offerto alla Madonna della Consolata più di cinquant’anni prima. Quelle conferme lo schiacciavano, offuscandogli la mente come un sortilegio in cui aveva la sensazione di annegare.
«Non era Efialte il colpevole» continuò Maria. «Come non lo sono Faucigny e i suoi, ma il loro arrivo non è certo frutto del caso, come non lo è questa guerra qui e ora.» La smorfia di disappunto fu come un cedimento sul viso di marmo. «I nemici alle porte di Torino ci hanno costretto a distogliere il nostro sguardo da ciò che succede all’interno delle mura, per fare… che cosa, non lo so.»
Gustìn scacciò un altro brivido. Esseri come Maria erano più potenti dei più potenti tra gli uomini. Eppure qualcuno era capace di manipolare quelli come lei, di manipolare sovrani, di scatenare guerre. Se per Maria era difficile immaginarne lo scopo, per Gustìn era del tutto impossibile. Poteva solo constatare l’astuzia sopraffina di un giocatore di scacchi dalla strategia imponderabile.
«Cosa vi aspettate dunque da me?» Lo chiese per riempire il silenzio, perché ormai aveva qualche idea in merito. Per qualche ragione, lui era in grado di vedere qualcosa che ai Cavalcanti, malgrado i loro poteri, non era concesso.
«Un uomo che va a rubare delle pecore farà attenzione al cane del pastore. Ma forse non si accorgerà delle pulci che infestano il cane.»
«E io sarei il vostro cane?»
«No» rispose Maria, con un tono colmo di rammarico. «Il cane sono io. Per questo ho bisogno di voi.»
Torino, 7 agosto 1706