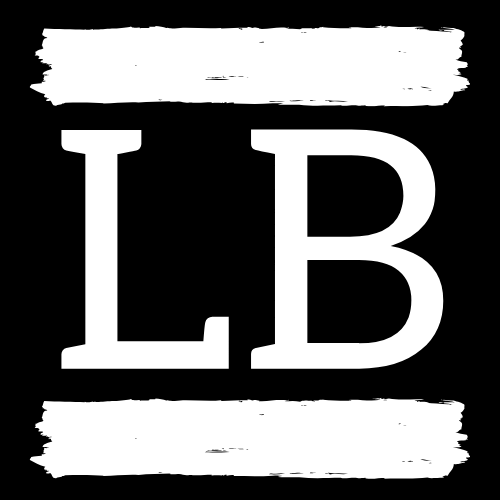Palazzo della Madama
Per
essere uno che gli sbirri guardavano come un cane con la rogna, Gustìn pensava di essere stato trattato troppo bene.
Nei suoi quattordici anni di vita aveva imparato a conoscere le carceri senatorie di Torino: stanzoni dal lezzo tremendo dov’erano stipati uomini, donne, bambini che dormivano per terra e si dividevano un unico grande vaso da notte. Cani e gatti randagi s’intrufolavano dalle minuscole finestre con le grate per contendere ai prigionieri il cibo raffermo e scambiarsi pulci e pidocchi.
Poi c’erano gli sbirri del Vicario, più duri e bastardi di quelli cui davano la caccia: quando prendevano qualcuno, in due lo tenevano fermo e il terzo lo picchia-va col bastone, mentre scommettevano quanto sarebbe durato senza svenire.
Eppure c’erano posti ancora peggiori delle carceri del Senato .Nella prigione di Miolans le celle erano chiamate “inferno”, e non solo perché stavano sottoterra. A Miraboc i condannati tiravano le cuoia in due settimane, sepolti nelle cisterne, mentre a Bard venivano calati con la corda in un pozzo scavato nella roccia: niente luce né cibo, né acqua… a meno che non piovesse, e allora se andava bene facevano il bagno, altrimenti annegavano con i topi.
Questa volta invece Gustìn era stato rinchiuso in una torre del palazzo che i torinesi chiamavano “il Castello”, e continuava a pensare che neppure nei suoi mo-menti migliori aveva vissuto in un posto più pulito, caldo e confortevole di quel-la… prigione. Se non avesse badato alle grate alla finestra , avrebbe potuto immaginare di essere nella stanza di una locanda per la gente di rango, con il letto di piume, lo scrittoio, il catino e la brocca per lavarsi.
Quel riguardo con cui era stato trattato, per la prima volta, lo riempiva di domande cui non riusciva a rispondere.Guardò la candela sullo scrittoio. La cera si consumava goccia dopo goccia, colava dallo stoppino, scendeva sullo stelo, circonfusa da un profilo di fiamma: insieme al suono delle campane di Torino quando chiamavano i fedeli alla Messa, era l’unico segno che il tempo continuava a scorrere.
Una chiave scricchiolò nella serratura, la porta della cella si aprì e lasciò intravedere delle ombre dall’altra parte. Una era la guardia che portava il cibo: la sua puzza di sudore e vestiti non lavati era inconfondibile.
Senza dire una parola, un uomo che Gustìn non aveva mai visto prima entrò nella cella e si mise a frugare nei cassetti dello scrittoio, sotto il cuscino, tra le coperte. Aveva la mole di un toro, ma le sue movenze avevano un qualcosa di felino e i suoi passi sul pavimento di pietra non facevano il minimo rumore.
«Siete il magistrato che mi deve interrogare?» gli chiese Gustìn.Vai contro il muro.
L’uomo non aveva parlato, ma il gesto e lo sguardo erano eloquenti: aveva terminato l’ispezione senza trovare nulla, e non era ancora soddisfatto. Gustìn lo studiò con più attenzione. Baffi curati. Tutti i denti al loro posto. Camicia di seta. Le fibbie delle scarpe erano d’argento, non di comune ottone.
«Monsieur?» insisté Gustìn.Muoviti.
Ancora un gesto, brusco questa volta. L’uomo aveva smesso di sorridere, se mai quella smorfia fosse stata un sorriso: i suoi occhi erano furbi e calmi insieme. Occhi di un giocatore che ha in mano carte vincenti.
Gustìn fece come gli era stato chiesto. Si sentì spingere contro la parete, tanto vicino da respirare la polvere d’intonaco, mentre una mano cominciava a tastargli con decisione la schiena e i fianchi.
Gocce di sudore gli gelarono la fronte: una delle tante volte che era stato ospite delle carceri senatorie, un ragazzo della sua età era stato portato via dai secondini che l’avevano violentato e riempito di botte.
S’inarcò all’indietro per usare il peso del corpo e sottrarsi alla presa. L’altro se lo aspettava e lo schiacciò di nuovo contro il muro. Gustìn chiuse gli occhi aspettandosi un pugno in testa o nelle reni, invece la mano che lo tastava scese lungo le gambe e fino alle caviglie, prima una poi l’altra.
«Cercate un’arma? Non ne ho. Potevate chiedermelo con gentilezza e vi risparmiavo la fatica. A voi sbirri servirebbe un po’ di stile.»«Felice non è uno sbirro» rispose una voce dalla porta. «E non vi ha chiesto nulla perché non può. E’ sordomuto.»
Gustìn si voltò ad affrontare un uomo dal cappello di feltro con il bordo consunto: aveva mani grosse, pelle abbronzata, occhi grigi e severi. Con quella parrucca ben pettinata ma anonima, la giacca di stoffa modesta, dava l’impressione di un artigiano con addosso gli abiti della festa. A vederlo accanto al sordomuto, si sarebbe detto il suo servitore.
«Siediti» ordinò a Gustìn, indicando il letto. Aveva una voce che sembrava un ringhio, bassa e cupa. Prese la sedia accanto allo scrittoio e vi si sedette, poi aprì il fascicolo che teneva in mano e cominciò a leggere:
«Augusto Graziadei, padre e madre ignoti, battezzato dai preti di Sant’Antonio il 16 maggio del 1672.»
Da almeno cinque anni la gente lo chiamava Gustìn, “Augustino”, e quel nome gli piaceva perché storpiava quello che i preti avevano scelto per lui.
«Sono io, monsieur.»
Con la coda dell’occhio notò che il sordomuto si era spostato accanto alla porta, certo per scoraggiare idee di fuga.
«Quattordici anni… eppure hai dato lavoro al Vicariato come una banda di briganti. Una lista di furti, truffe, imbrogli lunga da qui alla Porta Susina.»Gustìn si comandò di rimanere calmo. Aveva imparato che non bisogna mai voltare le spalle a un cane infuriato, perché altrimenti gli fai capire che hai paura. E sapeva che i cristiani non sono poi così diversi dalle bestie.
Fece un sorriso e rispose:
«Monsignore, uno fa quel che può per rimediare la pagnotta.»
«Sapete, Felice? Cinque anni fa il giovanotto ha provato a spaccare la testa a un gesuita con un bastone.» L’uomo aveva parlato in direzione del sordomuto, per farsi leggere le labbra. Felice spalancò gli occhi in un’espressione di esagerato stupore, poi mimò un applauso a cui Gustìn rispose con un prudente cenno del capo.
Era per questo che l’avevano rinchiuso? Per una storia vecchia ormai di sei anni? Ma perché nel Castello e non nelle carceri del Senato?
«Allora?» si sentì chiedere.
«Allora cosa?»
«Non hai nulla da dire a tua discolpa?»
«Non ho colpito abbastanza forte.»L’uomo lo fissò con un’occhiata che gli fece passare la voglia di fare lo spiritoso. No, quello non era uno sbirro come gli altri che aveva conosciuto.
«Forse invece non hai usato l’arma giusta.» Apparve una piega sul volto dallo sguardo gelido, ma Gustìn non era sicuro che fosse davvero un sorriso. «I gesuiti hanno la testa più dura del legno.»Poteva essere una battuta, eppure Gustìn non aveva il coraggio di ridere. Tornò ad arrovellarsi cercando di anticipare le conclusioni di quella strana conversazione. Ma per quanti sforzi facesse, non riusciva a capire dove il suo interlocutore volesse arrivare: di certo voleva spaventarlo, però, e ci riusciva maledettamente bene.
«Doveva averti fatto arrabbiare molto questo padre Olindo.»
«V’importa davvero saperlo?»
«No.»
L’uomo chiuse il fascicolo e lo posò sullo scrittoio. Infilò la mano in tasca e ne tirò fuori un oggetto che brillò alla luce della candela: una tabacchiera d’oro che perfino a un artigiano benestante sarebbe costata anni di sacrifici.
«Cosa ci facevi l’altra mattina nel palazzo di Rolando Boucheron?»
«Cercavo i gioielli» rispose Gustìn.
«I gioielli… davvero?»
«Sì, certo.»Passò un lungo istante. L’uomo ricominciò a parlare: «I servi dicono che sei entrato nel palazzo con una cesta di pane e ti sei presentato come il nuovo garzone del fornaio.»
«Era l’unico che entrava senza che nessuno gli facesse domande, ogni due giorni. Nessuno lo perquisiva.»
«Allora hai preso il suo posto e gli hai offerto in cambio quattro lire. Quattro lire sono molti soldi per un garzone.»Nessun segno di stupore o curiosità, ma nemmeno di disappunto. Gustìn non sapeva se l’interrogatorio stava andando bene o male, ma si era aspettato sberle e minacce, frusta e bastone. Non certo una chiacchierata come in un’osteria, davanti a un bicchiere di rosso.
L’uomo si servì di una manciata di tabacco e lo spinse nella narice.
«Quattro lire sono molte anche per uno come te» osservò ancora.
«Avevo dei risparmi da parte.»
«E te li sei giocati tutti.»
«Bisogna avere il coraggio di scommettere, se si vuole vincere, no?» Gustìn fu di nuovo trafitto da quello sguardo che gli faceva tremare le gambe.
«Vai avanti, Augusto. Come pensavi di uscire, una volta presi i gioielli?»
«Il retro del palazzo si affaccia su un cortile. C’è un olmo con un ramo vicino alla finestra del secondo piano: saltare giù sembrava uno scherzo.»
«Invece?»
«Non capisco.»
«Dove hai sbagliato?»
Nei giorni passati in cella, Gustìn aveva avuto abbastanza tempo da dare una ri-sposta almeno a quella domanda: «Chi avrebbe mai immaginato che un vecchio fosse così vigile… e così veloce con la spada…»
L’espressione dell’uomo s’indurì e Gustìn sentì il cuore mancare un colpo.“Ecco, adesso mi condanna.”
Trattenne il fiato. Due anni? Cinque, dieci? Forse meno, e prima o poi ci sarebbe stata un’amnistia: ce n’erano di continuo, per i reati minori. Bastava aspettare la nascita del prossimo figlio del Duca, cosa che sarebbe dovuta arrivare prima o poi, dal momento che Sua Altezza Reale non aveva ancora eredi maschi.
«Speravo di ricevere più collaborazione da parte tua.»
Gustìn rabbrividì. Quella voce gli faceva accapponare la pelle. Gli avrebbe messo paura anche se gli avesse offerto di andarsene libero e con i complimenti del Duca. «Non chiedo che di collaborare, monsieur.»
«Allora dimmi cosa cercavi in quel palazzo.»
«Io… ve l’ho detto…»
«Voglio la verità!»Gustìn dovette fare uno sforzo per non pisciarsi addosso. Si avvizzì come se le ossa fossero diventate di burro. Mai come in quel momento avrebbe voluto essere altrove: nelle carceri senatorie in mezzo alla feccia di Torino, in una cisterna di Miraboc o perfino nel pozzo di Bard.
«Co-cos’altro potrei cercare nella casa di un gioielliere? Non certo i quadri o i mobili… da solo non avrei potuto portarli via.»
«Mi stai dicendo che cercavi davvero i gioielli?»
«Non capisco… i Boucheron sono famosi…»
«Giuliano Boucheron è un orafo famoso, sì, e i suoi figli anche. Ma Rolando, cugino di Giuliano, non è un gioielliere. Davvero credi che ti terrei nel Palazzo della Madama per un semplice furto?»Gustìn era sconcertato. Nulla stava andando come aveva immaginato: «Di cosa mi state accusando, allora?»
«Rolando intrattiene dei rapporti, alla corte del Re di Francia. Le informazioni di cui giunge in possesso interessano il Duca Vittorio Amedeo. Allo stesso modo, qualcuno fedele ai Borbone vorrebbe impedire che quelle informazioni giungessero al Duca.»Gustìn si morse il labbro mentre si sforzava di non mettersi a tremare.
Per questo era stato isolato in una cella singola, senza avere contatti con nessuno: perché Boucheron era una spia dei Savoia, e lui, intrufolandosi nella sua abitazione, era accusato di essere una spia dei Borbone di Francia.
Per una spia la condanna era la forca, niente grazie né amnistie.
Quando riuscì a parlare, lo fece con un gemito: «Non lo sapevo… sono andato lì per i gioielli, ve lo giuro!»
«Taci. E ascolta quello che ho da dirti, perché la tua vita dipende da quello che deciderò di fare con te.»
«Sì, monsieur» ansimò Gustìn. «Grazie.»
«Mi chiamo Giovanni Battista Gropello, sono al servizio di Sua Altezza Reale il Duca di Savoia. In questi ultimi giorni sono accaduti eventi da cui dipendono il futuro del Ducato, il mio futuro, e quindi il tuo.»Il nome di Gropello non diceva niente a Gustìn. Ascoltò come gli era stato ordinato, con il sangue diventato ghiaccio.
«Forse saprai che il re di Francia condiziona le scelte politiche del Ducato, oc-cupa le nostre piazzeforti militari, minaccia di farci diventare una sua provincia. Ma le cose stanno per cambiare…»
Gustìn non s’interessava di politica. Sapeva che il governo era passato dalle mani della Madama Reale a quelle del figlio perché c’era stata una distribuzione di cibo gratuita. Sapeva che il Duca non gradiva la tutela di Luigi XIV, tanto cara invece a sua madre, perché lo aveva sentito dire per strada, tra i banchi del mercato, nelle taverne. I difficili rapporti di Vittorio Amedeo con Sua Maestà Cristianissima erano continua fonte di pettegolezzi, seconda solo a quelli che riguardavano gli insaziabili appetiti del Duca per il gentil sesso.«L’anno scorso» continuò Gropello, «Luigi ha revocato l’Editto di Nantes, mettendo fuori legge i “riformati”. Sai chi sono i riformati?»
«I Valdesi, credo. Monsieur.»
«Luigi ha obbligato il Duca a emanare un editto simile. I Valdesi devono convertirsi, demolire i templi, battezzare i bambini ed esiliare i predicatori.»
Gustìn non aveva mai conosciuto di persona un valdese, ma ne aveva sentito parlare sin dai tempi in cui viveva della carità dei preti, in cambio del tentativo di educarlo ai precetti del cattolicesimo.
«Non accetteranno mai» si azzardò a dire.
«Non hanno accettato, infatti. Il Duca deve condurre in Val di Pellice il suo esercito insieme a quello di Francia per fare… pulizia.»Ecco quello che stava accadendo in Val di Pellice: battaglioni di Francia e Savoia contro contadini armati di falci, vecchi fucili e coraggio. Ai civili sarebbe andata peggio: case in fiamme, donne violate, bimbi uccisi, bestie portate via. Fatti troppo lontani per dargli pensiero. Ne aveva altri a preoccuparlo, e prendevano la forma di un tratto di corda appeso al patibolo fuori dalle mura, vicino alle concerie di Borgo Dora.
«Avete detto che il mio futuro dipende da cosa deciderete di fare con me…»Gropello alzò lo sguardo dal fascicolo e mostrò un viso duro come l’acciaio.
«Il Duca mi ha onorato della sua fiducia. Se non tradirai la mia, diventerai più ricco di quanto tu abbia mai sognato.»
Gustìn comprese di essere con le spalle al muro: dopo che gli era stata mostrata la forca, ecco la speranza di una salvezza inattesa. Prendere o lasciare.
«Farò quello che volete.»
Gropello aspirò un’altra presa di tabacco, concedendosi tutto il tempo.
«Sua Altezza Reale vuole partecipare al Carnevale di Venezia l’anno prossimo. Mi ha incaricato di precederlo e di assicurarmi che il soggiorno sia adeguato ai suoi desideri. Partirò tra una settimana.»Gustìn si accigliò, man mano che si avvicinava alla verità. Il suo primo, assurdo pensiero era stato che il Duca avesse bisogno di consigli su un travestimento.
«Vuole incontrare gli imperiali… non è così?» Non era una mossa difficile da capire per uno come lui. I ladri e i contrabbandieri del Moschino lasciavano da parte le rivalità quando si trattava di affrontare gli sbirri o le bande di Borgo Dora. Così, per sfidare la Francia, il Duca di Savoia doveva cercare l’alleanza del più forte nemico del Re Sole: l’Austria degli Asburgo.
Lo sguardo di Gropello mostrò un cedimento e si ammorbidì in un sorriso divertito: «Ho bisogno di gente capace di guardare, ascoltare… e che al momento giusto non si faccia remore a commettere qualche piccola scelleratezza. Gente insospettabile, con un po’ di faccia tosta.»
Gustìn non era sicuro di aver capito: «Volete prendermi al vostro servizio?»
«Se rifiuti, tra due giorni penzolerai dalla forca.»
Gropello pronunciò quelle parole con la stessa indifferenza che avrebbe potuto dedicare alla scelta della salsa per il bollito, se quella rossa o quella al rafano.Dalla finestra della cella s’intravedeva il cielo, un mantello color blu cobalto in cui brillavano le stelle. Gustìn si lasciò accarezzare dall’aria fresca e il tumulto che si agitava in lui si placò lentamente. Si sorprese di sentirsi in pace.
Gropello uscì dalla cella, con Felice che lo seguiva come un’ombra. Prima di far chiudere la porta, disse: «Tornerò domani per conoscere la tua decisione.»
Gustìn lo inseguì con una domanda: «Perché proprio io?»
«Perché bisogna avere il coraggio di scommettere, se si vuole vincere. Arrivederci, Augusto.»
«Monsieur…?»
Il Conte non si voltò a guardarlo, ma Gustìn era sicuro che non si sarebbe perso nemmeno una parola.
«Mi chiamo Gustìn.»***
Vallone di Pramollo,
«… e tu che fai lì impalata?»
Bertina sussultò. Sua madre e Maddalena avevano smesso di parlare e la fissavano. Le fiamme del focolare dipingevano di rosso-dorato le labbra e gli occhi di sua sorella, e le mani robuste della mamma incrociate sulla camicia di lino.
«Cosa c’è?» mormorò Bertina.
«Lei chiede cosa c’è!» esclamò la mamma, incredula, e Maddalena: «Tesoro, saranno qui tra poco!»Bertina non aveva bisogno di sentirselo ripetere: bisognava scappare e non c’era più tempo da perdere. Cinque reggimenti sabaudi e decine di battaglioni volontari francesi venivano a bruciare i villaggi e uccidere i predicatori, a saccheggiare le case e costringere i prigionieri al battesimo o al martirio.
Era già successo trent’anni prima, quando il Duca aveva fatto massacrare e incarcerare gli abitanti d’interi villaggi: ma questa volta, dicevano gli anziani, sarebbe andata peggio di allora, perché i soldati di Catinat erano bestie ben più feroci di quelli del marchese di Pianezza.«Bertina?» insisté la mamma. «Vuoi sbrigarti?»
Bertina non disse che stava sognando a occhi aperti, e che nel suo sogno Niccolò era tornato per salvarla. A disagio, rispose chiedendo:
«Non prendiamo il vostro abito da sposa?»
«Cosa vuoi che m’importi del vestito?» si sentì rispondere. «Non riporterà in vita tuo padre!»
Era una donna forte, la mamma. Bertina la guardò staccare dal muro la beidana per appenderla alla cintura, come facevano gli uomini. Fino a quel momento gliel’aveva sempre vista usare per falciare il fieno e pulire dai rami i tronchi per il focolare, ma non era poi troppo diversa da una sciabola da cavaliere.«Forza, muovetevi!» comandò la mamma. «Vi aspetto all’inizio del bosco!»
«Vieni, Bertina: andiamo a prendere le mie cose» disse Maddalena, mettendole un braccio intorno alla spalla. Tante volte Bertina aveva provato invidia per le sue sopracciglia folte, la forma del viso aggraziata e la pelle liscia. Portava sempre i capelli ben pettinati, con la riga nel mezzo e le trecce legate dietro la testa: adesso invece la sua chioma era scompigliata, e il bagliore tremolante del lume faceva brillare in maniera sinistra le lacrime che le rigavano le guance.La paura non ha riguardo per la bellezza, pensò Bertina. Si chiese se quelle parole le avesse sentite da Niccolò o se avrebbe potuto suggerirgliele, un giorno, per comporre una nuova canzone.
Mentre seguiva sua sorella lungo il sentiero tra le capanne, alzò gli occhi al cielo e ricordò di quand’era andata a guardare la luna con Niccolò, sgusciando fuori dalla finestra mentre la mamma dormiva… e poi lui le aveva dato un bacio.
Scosse la testa. No, quella storia non era mai successa se non nella sua fantasia, anche se l’aveva desiderata così tante volte, così tante volte immaginata, che spesso la confondeva con la verità.Un vento gelido e cattivo s’insinuava tra gli alberi e le capanne, sferzando le mani e il viso. Bertina inspirò l’aria, satura del profumo dei boschi, mentre camminava incurvata e con la testa china. Faticava a stare dietro a sua sorella, che pure era appesantita dal ventre rigonfio.
«Non ti dovresti stancare» ansimò. «Il tuo bambino…»
Maddalena le fece cenno di tacere: «Ascolta.»Dal fondo della vallata giungeva una specie di rimbombo, simile a quello di un tuono che chiama a raccolta le nubi di un temporale. Guardando in quella direzione s’intravedevano bagliori come di lampi rossastri.
I francesi bombardavano le barricate dove gli uomini del villaggio cercavano di opporre resistenza: anche Paolo, il marito di Maddalena, era là. Bertina pensò che quand’era partito non gli aveva detto nulla di gentile.«Buon Dio!» esclamò Maddalena. «Sono quasi arrivati!»
Bertina seguì lo sguardo inorridito di sua sorella e finalmente vide un enorme serpente di fiamme vive che s’inerpicava sulle pendici del colle Laz Arâ. Soldati che marciavano in fila con le torce sollevate.
Si trascinarono fino alla casa in cui Maddalena viveva con suo marito. Alla luce della lanterna, presero gli zaini già pieni di tutto il cibo possibile, perché non sapevano per quanto tempo avrebbero dovuto nascondersi: formaggio, gallette, fette di lardo e prosciutto affumicato.
Bertina avvolse negli stracci il piatto dipinto che apparteneva alla loro famiglia da prima che lei nascesse, e che la mamma aveva regalato a Maddalena il giorno del matrimonio.«Cosa succederà adesso?» Faticava a parlare, la voce impigliata in gola. La sua unica certezza era che avrebbero trascorso la notte nel bosco e al buio, pregando che i francesi si accontentassero di saccheggiare il villaggio.
«Andrà tutto bene» la rassicurò sua sorella. «Dio non lascerà che ci capiti qual-cosa di brutto.»
Un urlo stridulo arrivò da fuori, un sibilo con una nota troppo acuta. Non era il verso di un animale. Poi uno scoppio fortissimo.
Bertina guardò i bagliori che penetravano dalla porta spalancata, rischiarando il prato davanti alla casa. E di colpo ebbe la certezza che, una volta uscita da lì, non sarebbe più tornata a casa. Mai più.«Pensi che… riuscirà a trovarmi, anche se ce ne andiamo via…?»
«Chi?»
«Niccolò…»
Sua sorella si fermò a guardarla, ma le ombre giocavano con il suo viso e Bertina non riusciva a capire se era arrabbiata, o stupita, o cos’altro. Un boato risuonò tra i fianchi della valle, poi di nuovo, più vicino. Molto più vicino.
«Santo Cielo, Bertina! Non immaginavo che… Non avrai…»
«No, no!… è che… spero…»
Maddalena chiuse la sacca e se la caricò sulle spalle.
«È un poeta» borbottò, e uscì senza dire altro.Bertina la seguì, domandandosi cosa volesse dire. Di una cosa era certa: Niccolò non era solo un poeta.
Era arrivato in Val di Pellice con una sacca da viaggio, la sua voce d’angelo, i suoi racconti e la musica di un flauto. Quando raccontava le buffe avventure di Calandrino tutti ridevano fino alle lacrime. E le donne si chiedevano se quella Laura di cui parlavano le sue poesie d’amore fosse la sua fidanzata lontana, e avrebbero voluto essere al posto suo.
Niccolò era così bello da far girare la testa quando passava , ed era più intelligente e raffinato di tutti i ragazzi del villaggio, reclusi tra i monti come le capre che facevano pascolare.
Bertina dell’amore non sapeva ancora niente, ma ogni volta che guardava Niccolò sentiva il cuore tuffarsi in basso e risalire, e lo stomaco aggrovigliarsi come in preda alla fame.
La mamma l’aveva messa in guardia da lui, come tutte le mamme del villaggio avevano fatto con le loro figlie.
“I vagabondi come lui vanno e vengono, e scombinano tutto come il vento.”
La mamma aveva ragione, perché Niccolò se n’era andato e non aveva dato baci a Bertina, né fatto promesse, né pronunciato parole d’amore. Eppure Bertina si sentiva vuota e infelice come non mai.Un suono calò su di loro, no, era un insieme di suoni, un coro. Le grida di guerra dei soldati francesi che stavano piombando sul villaggio.
«Andiamo, presto!» urlò Maddalena.
Procedevano più in fretta che potevano; anche sua sorella faticava a vedere dove metteva i piedi e tastava il terreno per non cadere in una buca e far male al suo bambino.
Tornarono al punto in cui la linea dei muri di pietra delle case si apriva sulla vallata sottostante. Si fermarono a prendere fiato e Bertina vide le molte sagome di uomini che si avvicinavano. Alcuni impugnavano torce, altri i moschetti. Le baionette brillavano alla luce cangiante delle fiamme.
Una morsa le strinse il cuore e il terrore si abbatté su di lei come un maglio. Prese Maddalena per un braccio, e cominciò a tirarla verso il bosco, ma sua sorella la trattenne: «Dobbiamo prima raggiungere la mamma!»Quello era l’accordo, ma era sbagliato: la casa di Maddalena era più vicina al bosco, e quella della mamma ai francesi che arrivavano. Bertina si chiese come avesse fatto la mamma a non pensarci, e come facesse Maddalena a non accorgersene.
Ci fu un nuovo sibilo, come lo strillo di un’aquila. Un boato. La terra tremò e la stalla della famiglia Pont, davanti a loro, esplose in un lampo bianco.
Bertina sentì un soffio d’aria calda scompigliarle i capelli e turbinare nella stoffa della camicia, mentre intorno piovevano terra e ciottoli. Qualcosa di umido e pesante le cadde sulla spalla, strappandole un grido di dolore: pensava si trattasse di un ramo, poi riconobbe quello che restava della zampa di una vacca.
Urlò finché ebbe fiato.Intorno a lei i soldati dilagavano come un torrente, eppure si muovevano con disciplina: divisi in gruppi di due o tre, circondavano una casa, sfondavano la porta, entravano sparando e gridando. La gente del villaggio correva in disordine, da tutte le parti: una donna con una ragazzina che piangeva, un vecchio uomo magro con un prosciutto tra le braccia, due bambini che vagavano inebetiti.
Bertina cercò con lo sguardo sua madre. Credette di riconoscerla in una donna che correva cercando di tenere uniti tre bambini e un cane: guardando meglio, comprese che non era lei. Maddalena era senza scialle e senza la sacca: doveva averli perduti lungo il tragitto, chissà dove. Era fredda e rigida come un guscio vuoto, e aveva cominciato a cantare una ninna nanna mentre si accarezzava il ventre. Bertina la tirò per la mano e insieme girarono attorno a una stalla, nascondendosi dietro ai recinti per non farsi vedere da un gruppo di soldati che stava passando molto vicino.
L’aria era piena di insulti e bestemmie, pianti e lamenti. Perfino le bestie gridavano terrorizzate. Bertina riconobbe Marcello: “Pietà!” strillava, “pietà!”.
Fino a due anni prima giocavano insieme, e lui le tirava le trecce quando litigavano. Ci fu uno sparo e Marcello smise di gridare.
Una vecchia con una gonna scura si trascinava sui gomiti chiedendo aiuto con voce spaventata e stridula. Apparvero due soldati con i fucili in mano.
«La voici! » disse uno ridendo, e puntò l’arma. Bertina voltò le spalle prima di sentire il colpo .Schegge di fuoco vorticavano ovunque voltasse lo sguardo, sferzando le capanne in una danza di ombre e luci: la paglia in fiamme saliva al cielo come uno sciame di vespe scintillanti e l’odore di bruciato aggrediva le narici, togliendo il respiro.
«Dobbiamo tornare indietro» disse Maddalena. «Ho dimenticato lo scialle.»
Sembrava tranquilla, ma aveva le guance rigate di lacrime. Com’era diversa dalla ragazza sorridente che aveva fatto innamorare tutti i giovani del villaggio.
«Non ti serve lo scialle!» la zittì Bertina.Alcune ombre sfrecciarono a poca distanza. Bertina spinse la sorella dietro un muro prima che gli inseguitori le vedessero. Guardò i francesi abbattere due ragazzi con una scarica di fucile e avventarsi su di loro come un branco di lupi, per finirli con le baionette.
«Maddalena, ti prego!» Bertina sentiva la propria voce parlare dal di fuori, come se fosse stata di qualcun altro e non la sua.
«Lo scialle… per il bambino…» si lamentò Maddalena.
Il tuo bambino avrà freddo, pensò Bertina da un angolo dentro di sé fatto di gelo e paura. Il tuo bambino avrà freddo e io non vedrò mai più Niccolò.Udì un sibilo, un ronzio simile a un frullo d’api, poi un tonfo umido.
Maddalena fece una specie di “oh”, poi le cadde addosso, spingendola a terra, dove l’odore di erba umida era così forte da togliere il fiato.Bertina cominciò a divincolarsi per togliersi di sotto. La sua mano toccò qualcosa di appiccicoso sulla schiena di sua sorella. Sentì lo stomaco aggrovigliarsi. Un fiore scuro era sbocciato sulla camicetta di lino bianco di Maddalena, poco sotto le scapole. Era morta. E il suo bambino forse continuava a scalciare, in attesa di nascere: lei non si era accorta di morire, lui non sapeva che non sarebbe nato mai.
Bertina aveva voglia di piangere, ma era come se le lacrime e il dolore fossero diventati così grandi da non poter più uscire.Cominciò a camminare senza una direzione precisa.
Un bambino e una bambina di quattro o cinque anni erano in mezzo alla confusione, piangevano tenendosi per mano. Un altro di poco più grande, forse il fratello, cercava di entrare in una stalla in fiamme, chiamando sua madre. Tutt’intorno i francesi si muovevano e sparavano, entravano nelle case, poi usci-vano con giubbe di pelliccia e piatti di porcellana sotto il braccio.Bertina cominciò a ripetere le parole della poesia di Niccolò, quella che sembrava una dichiarazione d’amore.
“Laura soave dal viso chiaro muove col suon delle parole accorte…
… parole accorte…
… per far dolce sereno…
… uno spirito gentil del paradiso…”Ripeteva la poesia e poi si ripeteva che lui l’avrebbe sentita, dovunque fosse in quel momento. L’avrebbe sentita e sarebbe tornato a salvarla.
Barcollava e le facevano male gli occhi e la gola per il fumo: sapeva che stava ripetendo la poesia, ma non riusciva a sentire la sua voce. Coperta dalle urla, dai nitriti dei cavalli, dagli spari.
Le travi della casa di fronte si spezzarono con uno schianto. Una colonna di fuoco ondeggiò sopra i rottami anneriti, allargandosi come la chioma di un albero. Vacillò e ricadde, esplodendo in una nuvola porpora e arancione. Da dentro si sentiva un orrendo grido di terrore, il grido di qualcuno che sta vedendo arrivare la propria morte.Bertina si rese conto che era la sua casa, e che la voce era quella della mamma.
Fece un passo avanti, inciampò e cadde in ginocchio, le mani affondarono nella terra umida. Cominciò a singhiozzare, urlò di nuovo, a lungo. Il fumo era ovunque, il caldo insopportabile.
Bertina adesso stava andando verso il bosco, un piede dopo l’altro, come guidata da una volontà non sua. Camminò tra le capanne in fiamme e la gente del villaggio che moriva.Quattro uomini apparvero da dietro una stalla bloccandole la strada. Le fiamme gettavano bagliori sinistri sulle canne dei moschetti e sulle baionette innestate.
Uno di loro sollevò l’arma, un altro disse:
«No! Elle est jolie…»
Bertina guardò quei visi sconosciuti, crudeli e ripugnanti, e mentre si avvicinavano comprese cosa volevano da lei. Una voce, da qualche parte nella sua testa, le gridava che doveva scappare, ma i suoi piedi erano diventati di pietra. Non fu nemmeno capace di chiedere aiuto.
In quel momento, appena prima che i soldati le fossero addosso, riuscì solo a pensare che sarebbe stato bello aver baciato Niccolò almeno una volta.